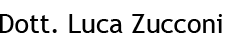Il dolore appartiene a quella ristretta sfera di esperienze che, da sempre, appassionano ed inquietano il pensiero umano. L’esperienza del dolore appare per molti versi incomprensibile, inaccettabile, ingiusta. Posto di fronte al terribile potere distruttivo del dolore,ognuno di noi si è chiesto almeno una volta a cosa serve, a cosa mai può servire, la sofferenza.
Il dolore appartiene a quella ristretta sfera di esperienze che, da sempre, appassionano ed inquietano il pensiero umano. L’esperienza del dolore appare per molti versi incomprensibile, inaccettabile, ingiusta. Posto di fronte al terribile potere distruttivo del dolore,ognuno di noi si è chiesto almeno una volta a cosa serve, a cosa mai può servire, la sofferenza.
Nel pensiero occidentale, la riflessione sulla funzione del dolore ha origini antiche e saldamente intrecciate al problema morale, alla questione del bene e del male. Non stupisce, quindi, se, nella nostra cultura le diverse interpretazioni del dolore siano spesso il riflesso del pensiero religioso dominante.
In particolare il cristianesimo ha contribuito ad assegnare al dolore una funzione sia punitiva che di riscatto e purificazione. Pertanto, nella cultura occidentale, è prevalsa e si è concretizzata una visione salvifica ed espiatoria del dolore. Tuttavia, secondo alcuni Autori (Scarry E. 1990; Fromm E. 1964), una rilettura attenta delle Sacre Scritture consente di individuare anche nella tradizione giudaico-cristiana una funzione iniziatica del dolore. Si consideri, per esempio, l’episodio della consegna del dolore da parte di Dio ad Adamo, fatto che segna il passaggio dallo stato di “creatura” allo stato di “individuo”, con il conseguente riconoscimento di compiti e responsabilità.
Ma è il Nuovo Testamento a rafforzare l’idea che il dolore sia una punizione da espiare fino in fondo. Nei Vangeli, in più di un’occasione, Dio esercita il suo potere e la sua benevolenza attraverso atti di guarigione; la presenza o la persistenza del dolore diventano il segnale di un alterato rapporto dell’uomo con il divino. A differenza di altre religioni, il cristianesimo spesso identifica il dolore con il male e con il demone, tanto è vero che le su citate guarigioni sono state descritte come veri e propri esorcismi. Nelle religioni orientali, il dolore nasce ogni qualvolta l’essere umano tenta di sovvertire la sua natura o i limiti che gli ha imposto il suo Creatore.
Questa considerazione è chiaramente espressa nel Buddismo: l’uomo può salvarsi dalla sofferenza soltanto se si ridesta dalle sue illusioni e diventa consapevole che la sua realtà è manchevole
Nelle discipline orientali, il dolore acquista soprattutto il senso o la funzione di rilevazione e di opportunità per divenire consapevoli, capire, accettare.
Senza produrre grandi sforzi, ognuno di noi, può facilmente notare come queste idee “religiose” si presentino, più o meno intatte, nelle nostre convinzioni o espressioni quotidiane.
Tutta questa premessa per dire come tali concezioni, valutate spesso come estranee o inutili ai fini della ricerca medico-scientifica, svolgono invece un ruolo fondamentale, poiché la percezione del significato e della funzione del dolore cronico influenza enormemente il vissuto sensoriale del dolore stesso e quindi la capacità di resistergli e sopportarlo, utilizzarlo e fronteggiarlo, curarlo o guarirlo (Mount B. 1988; Browne D. 1984).
Per esempio Craig (1988) ha ben documentato come l’intensità dei dolori intrattabili del cancro varia al variare del significato religioso che il paziente attribuisce alla malattia. Aldwin (1993) ha svolto una ricerca analoga con persone che avevano subito esperienze traumatiche estreme, giungendo a conclusioni molto simili a quelle di Craig. Tutto ciò, a ben vedere, conferisce una responsabilità specifica a quanti contribuiscono a modificare e proporre strutture interpretative del dolore.
L’approccio scientifico al dolore cronico (sia esso legato ad un’artrite progressiva, ad un cancro, all’AIDS), esperienza che coinvolge la totalità dell’individuo, deve necessariamente essere formulato in termini di approccio olistico, finalizzato cioè sia alla dimensione fisica-sensoriale del dolore, sia a quella affettivo-emozionale. Non ha molto senso, quindi, distinguere il dolore fisico da quello psichico o “il dolore del corpo” dal “dolore dello spirito”: ogni esperienza dolorosa è caratterizzata da fenomeni fisici, psichici, relazionali, sociali. Il dolore cronico non rappresenta un segnale d’allarme come può essere un dolore acuto, così come non ha una spinta motivazionale ben presente in un dolore acuto (nel dolore acuto la sofferenza genera la ricerca di una soluzione efficace), quindi il dolore cronico introduce, nel vissuto del paziente, con patologie terminali, un ulteriore ed insopportabile livello di perdita.
Il paziente è privato, in questo modo, anche della residua possibilità di godere o vivere pienamente l’ultimo periodo di vita; non è raro notare anche nei familiari e negli amici reazioni che compromettono un sereno o equilibrato rapporto con l’ammalato.
Il dolore, infine, ricorda continuamente al paziente la presenza del male riattualizzando, con maggiore violenza, sentimenti di punizione, paura e perdita. In questi casi, si conclama con maggiore frequenza un profondo stato depressivo e si accentuano fenomeni di rifiuto, inibizione e di isolamento sociale.
Secondo dati epidemiologici, la prevalenza di disturbi o disordini mentali è, nei malati terminali, tre volte maggiore rispetto alla popolazione generale. Prevalgono i disturbi dell’affettività che, nella maggior parte dei casi, sono caratterizzati in egual misura da disturbi di carattere ansioso e disturbi di tipo depressivo. Soltanto il 13% dei pazienti presenta esclusivamente una depressione maggiore e solo il 4% unicamente uno stato conclamato di ansia (Derogatis L.R. 1999).
Va rilevata la costante presenza, nel malato terminale, di grosse quote di ansia che, spesso, assumono carattere ipocondriaco e fobico.
Sotto questo aspetto, la presenza del dolore accentua enormemente sia le angosce ipocondriache che le paura di ulteriori sofferenze, mutilazioni e morte. In questi pazienti, l’incertezza continua e l’incapacità di spiegarsi cosa avviene nell’organismo, genera un costante stato d’allarme nell’organismo dell’ammalato, con conseguenze che coinvolgono pesantemente il sistema immunitario e neurovegetativo. Non a caso i pazienti terminali con dolori persistenti hanno una vita più breve rispetto a malati terminali che non soffrono. Le alterazioni comportamentali che il dolore cronico genera nella persona malata sono tali da compromettere l’intera esistenza del paziente e, da questo punta di vista, la persistenza della sofferenza può essere considerata una delle principali cause di disabilità e/o inabilità sociale. Il ricorso continuo a cure ed interventi, le frequenti assenze lavorative, il progressivo ritiro della vita sociale e lo sviluppo dei disturbi psichici citati creano nel sofferente un circolo vizioso che non sembra conoscere via d’uscita. Ciò comporta, l’assunzione da parte del malato, di un ruolo che si caratterizza per la sua estrema particolarità: la preoccupazione per la propria salute fisica diventa assoluta ed invasiva e spesso, attorno al sintomo doloroso, il paziente organizza un’autentica ruminazione ossessiva. L’ineludibilità della condizione cronica del paziente, disturba profondamente la relazione tra il malato e coloro che, a vario titolo sono coinvolti nel processo di cura.
Nel caso specifico di uno psicologo si può notare come il ruolo terapeutico venga costantemente messo in discussione dalla persistenza del dolore che offre al paziente numerose occasioni per attaccare o manipolare la figura curante che, dal canto suo, vive spesso con frustrazione quella che in fondo è una profonda ferita narcisistica. In altri casi, la persistenza del dolore aiuta a stabilire relazioni transferali molto intense; è noto che alcuni pazienti mostrano una chiara capacità di controllare l’intensità del loro dolore allo scopo di compiacere o punire la figura curante (Craig K 1988).
Gli psicologi che si confrontano con le sindromi algiche terminali si avvicinano, forse, all’esperienza che maggiormente mostra il potere distruttivo del dolore.
Se è vero, come ha osservato Scarry, che l’esplosione del dolore nel corpo comporta il dissolvimento di tutto ciò che fonda il corpo come persona, è pur vero che la funzione de-oggettivante del dolore è un fenomeno tangibile (Storace, Fusco 1998). Le quote d’angoscia che si riattualizzano in questi casi sono tali da condizionare il comportamento o l’atteggiamento di chi, di fronte a questo dolore, non ha che la limitatezza delle proprie strutture interpretative.
E’ proprio a questo livello, hanno argomentato Storace e Fusco (1998), che possono intervenire psicologi, andando a creare strutture di conoscenza che diano al dolore la possibilità di esprimersi al di là delle nostre interpretazioni. Diventa particolarmente utile lo sforzo di coloro che tentano di costruire un ponte che permetta al malato terminale di comunicare e rendere visibile la sua esperienza, affinché il dolore possa essere osservato dalla parte di chi questo dolore lo soffre. Questa comprensione del dolore non può che essere facilitata se si considerano le idee per così dire religiose che accompagnano certe esperienze. Ma ascoltare il dolore estremo può essere un compito estremamente arduo sia per ragioni derivanti dall’impostazione medica, sia per il contro-transfert che il dolore genera in chi lo ascolta. Sempre rifacendosi a Storace e Fusco possiamo affermare che la medicina moderna affronta e cura il dolore in maniera violenta. Infatti il mito della medicina contemporanea, per dirla con Patrick Wall (1988), è la ricerca della “causa” e poco conta se nel frattempo chi soffre non ha sollievo o scampo. Del resto questa poca attenzione al malato come persona è testimoniata dalla diffusa richiesta di “umanizzare” i reparti o il diffondersi, tra i sofferenti cronici, di pratiche di cura che affermano l’irriducibile bisogno di una medicina “naturale” ossia rispettosa dei ritmi e degli eventi dell’esistenza. E’ triste osservare che il sogno onnipotente di “eliminare il dolore”, tipico della cultura e della scienza occidentale, ha reso, in un certo senso, il dolore ancora più forte. Questa impostazione medica non favorisce certamente le condizioni per un buon lavoro psicologico, ma rapportarsi con il dolore senza soluzione è comunque estremamente difficile per una figura d’ascolto perché è ben presente e visibile quel limite personale che spesso si tende a perdere. La difficoltà specifica consiste nell’ascoltare una sofferenza enorme che non terminerà, per parafrasare Frieda Fromm-Reichmann, con “un giardino di rose.” Tuttavia, giungendo a conclusione, ritengo sia doveroso ricordare che costruendo spazi di espressione restituiamo al dolore la sua permanenza all’interno della cura e della vita.